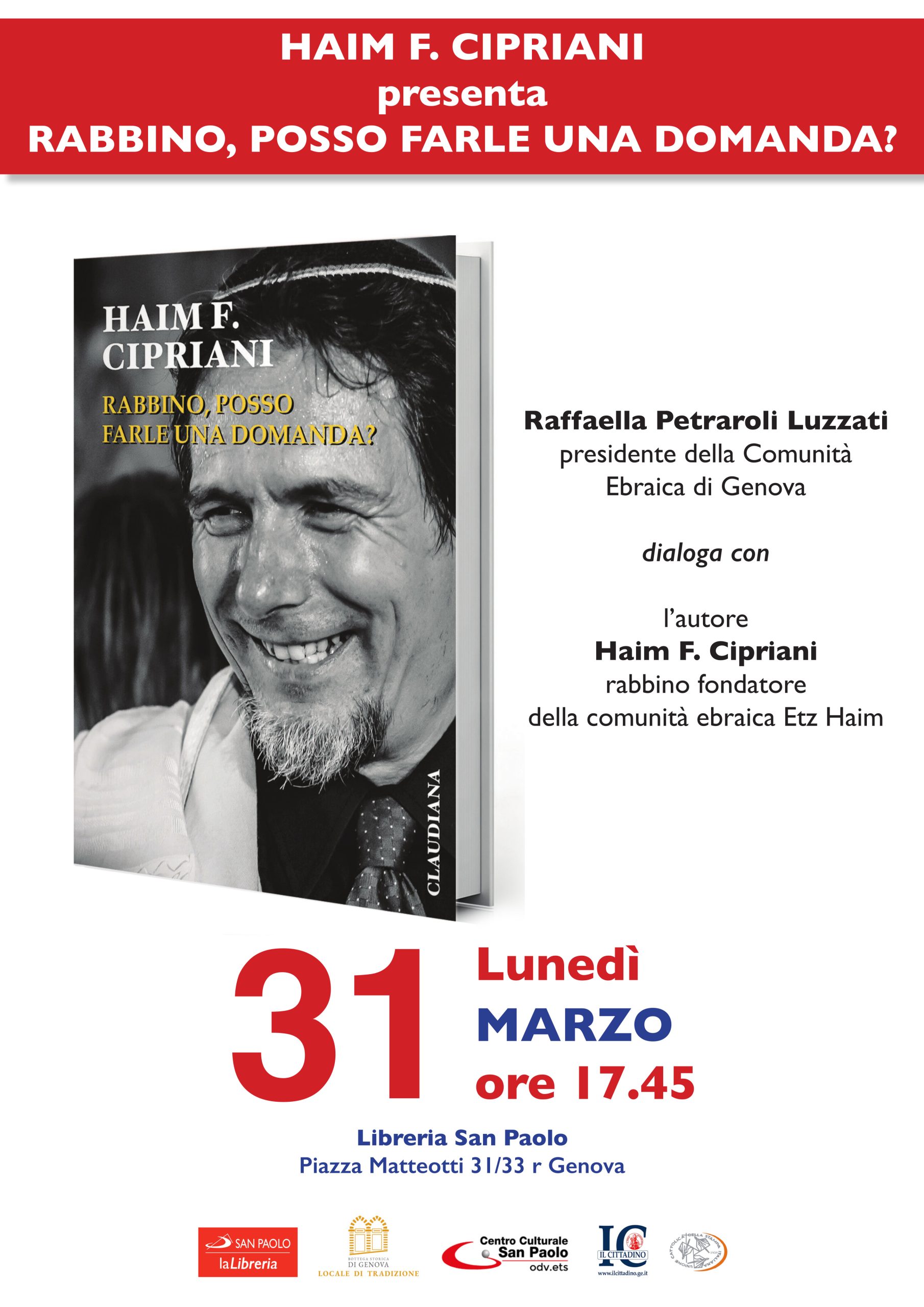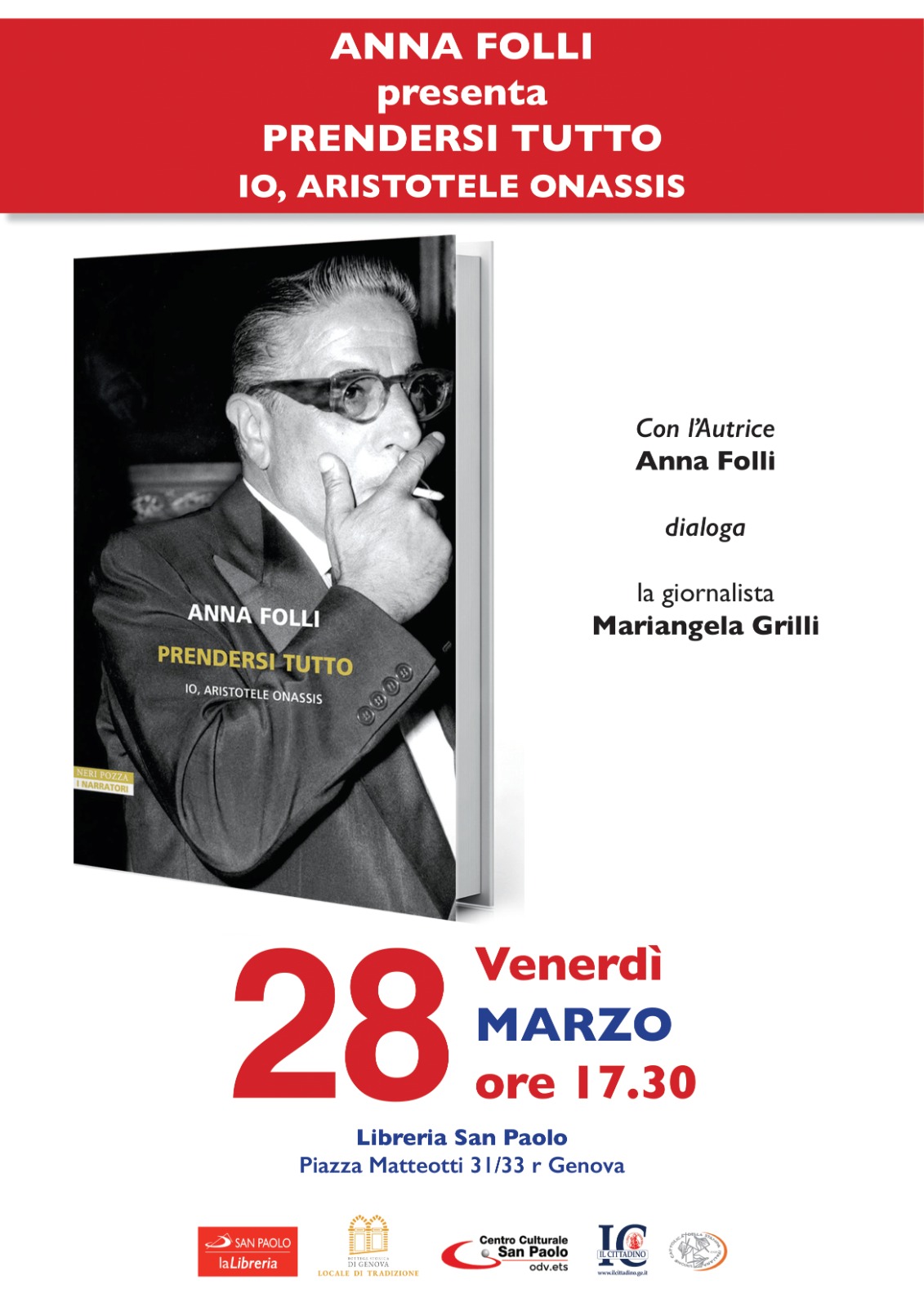Il Vangelo di domenica 30 marzo

IV DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO C
Dal Vangelo secondo Luca
Lc 15,1-3.11-32
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola:
«Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».
1 ‑ Rallégrati Gerusalemme ‑ La liturgia odierna esulta di gioia perché l’umanità è stata liberata dalla ‘infamia di Egitto’, cioè dalla stessa condizione servile in cui si trovava il popolo ebraico prima della liberazione: senza patria e famiglia, senza padre e senza fratelli, senza dignità e libertà di popolo e di persona. Il peccato produce un effetto spirituale equivalente: ci rende schiavi delle passioni proprie e altrui. Ma il Signore ‘è vicino a chi lo cerca, lo libera da tutte le angosce’, quindi ci restituisce libertà, verità, gioia vera.
2 ‑ La nostra casa ‑ Lo sfondo della parabola del figliol prodigo è l’immensa bontà, misericordia e intuito educativo del padre. Egli vuole il bene autentico dei due figli, ma non li obbliga mai: la sua casa, i suoi averi, il tipo di lavoro non devono avere mai la precedenza su un rapporto di amore e libertà filiale. La parabola è di una bruciante attualità, sia perché coglie alla perfezione il significato genuino dei rapporti dell’uomo con Dio e dell’uomo con gli uomini, sia perché oggi questi rapporti sono nuovamente in crisi. L’uomo, come il giovane figlio della parabola, è troppo preoccupato di riprendersi la sua assoluta libertà e indipendenza, parlando solo di diritti, ma non di doveri.
3 ‑ Essere figli – ‘Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo’: parole piene di sapienza, di gran cuore e di senso pratico per ricordarci che siamo soltanto frutto dell’amore infinito di un Padre generosissimo e, se ci allontaniamo da Lui, non potremo certo sopravvivere. Il primo passo della riconciliazione è proprio ‘tornare’ ad amare Dio‑Padre con tutto il cuore, la mente e le forze: Lui è il primo, il centro, il tutto. Il paese ‘lontano’, di cui parla la parabola, è la situazione interiore e ambientale in cui ci si dimentica del tutto di Dio e si vive quindi come se non ci fosse. L’ateismo e l’agnosticismo, imperanti oggi, creano effettivamente questa condizione disperante di solitudine, perché ci siamo condannati a vivere facendo a meno di Dio e degli altri.
4 ‑ Essere fratelli – Se è vero il criterio del Padre verso il figlio: ‘Tutto ciò che è mio è tuo’, anche il rapporto tra fratelli è identico: ‘Tutto ciò che è mio è di tutti’. Siamo infatti tutti fratelli perché deriviamo dal cuore dello stesso Padre e tutti siamo amati come figli nel Figlio con un identico amore paterno. Ecco il profondo senso esistenziale cristiano delle parole di Paolo: ‘Se uno è in Cristo è una creatura nuova’. Ciò significa anche che tutti dobbiamo amarci con lo stesso amore con cui il Padre ama il Figlio prediletto; per questo Gesù può dirci: ‘Amatevi come io vi ho amati’. E S. Agostino commenta: ‘Cesseranno di essere nostri fratelli allorché avranno cessato di dire: Padre nostro’ (Discorso 357,4). Quel ‘nostro’ evidenzia dunque due rapporti: Io e Gesù, io e tutti gli uomini. Ecco allora il secondo passo della riconciliazione quaresimale: ‘tornare’ ad amare gli altri in piena comunione in quanto fratelli in Gesù.
5 – Punti concreti ‑ a) Domandiamoci se, nei confronti di Dio, siamo figli o mercenari o servi. Un clima di paura, insofferenza, torpore e meschino ricatto non denota certamente il vero amore filiale! Qui si tratta di fare tutto unicamente per amore di Dio, senza alcun tipo di interesse, soffrendo di non amarlo mai abbastanza. b) E in famiglia? Nella società? Nella Chiesa? Forse anche noi, senza rendercene conto, ‘abbiamo chiesto la parte del patrimonio che ci spetta’, che è la vita, per amministrarcela in assoluta libertà e in esclusiva, davanti a Dio e agli altri. Mentre, in una vera famiglia, tutto deve essere comune a tutti, ma sempre considerato come un qualcosa di personale.